La città dei vivi è un libro non convenzionale, per molte ragioni: in primo luogo qui il linguaggio è trasparente, è un libro di vite, di corpi, di pulsioni, un romanzo perfettamente costruito, si potrebbe dire, se non si sapesse che tutto ciò che Nicola Lagioia ha scritto è realmente accaduto. È un libro realista? Sì, dal punto di vista dei fatti, dell’aderenza del racconto a una forma meticolosa di ricostruzione in cui l’autore sembra quasi sparire. Non lo è completamente, per fortuna, perché l’autore non scompare, assottiglia il linguaggio, si diceva, riporta la vita pura, la strada, il fuori, ma diventa personaggio, non solo narratore, e come tale è moralmente coinvolto nella tragica vicenda dell’omicidio Varani che ha sconvolto la città di Roma. Eppure Roma resta la città dei vivi, non la città dei morti, sono i vivi a parlare appropriandosi i morti, è sempre così.
L’indagine sociologica di Lagioia portata alle estreme conseguenze produce un’identificazione collettiva con il carnefice, non possiamo mai dire davvero: ecco il pazzo, il diverso, perché quando vediamo, sentiamo, leggiamo Marco Prato, sappiamo benissimo che in ognuno di noi c’è qualcosa che gli somiglia. Allora l’inchiesta si rivolge alla città? Roma? O forse al mondo intero, a ciò che siamo diventati. È un libro di voci, a suo modo postmoderno, la verità non emerge mai del tutto, se per verità non intendiamo solo l’efferatezza dell’atto, l’incomprensibilità del sacrificio dell’innocente, del sacrificio del più fragile dal punto di vista di classe, e di spirito (“Beati i poveri in spirito, perché loro è il regno dei cieli”), se di spirito possiamo ancora parlare senza essere perciò relegati al rango di visionari, conservatori, ma intendiamo il motivo intimo che tutti ci muove in questo teatro di marionette chiamato società.
«Hai idea del culo che mi sono dovuto fare per sfangarla in un posto come questo? Roma è una città che non produce più niente, - scosse la testa – non ci sono industrie, non c’è cultura d’impresa, l’economia è parassitaria, il turismo è di terz’ordine. I ministeri, il vaticano, la Rai, i tribunali… ecco di cos’è fatta Roma, una città che produce ormai solo potere, potere che ricade su altro potere, che schiaccia altro potere, che concima altro potere, il tutto senza mai un progresso, è normale che la gente poi impazzisce».
Qui è Stefano a parlare, un personaggio secondario, se proprio esistono protagonisti in questo libro, che ha come protagonista forse né Prato, né Foffo, né Varani ma la decadenza, l’assassinio neanche premeditato, solo casuale, di ogni residuo di umana dignità. È una denuncia, un avviso. Dobbiamo prestare attenzione a ciò che siamo diventati, dobbiamo prestare attenzione alle reali pulsioni che muovono il nostro animo, al modo in cui costruiamo la nostra identità, e a chi lasciamo invece ai margini, a soffocare.
«In un mondo che ti giudica senza darti una seconda possibilità, Marco sembrava dover frugare ogni sospetto sull’ipotesi di avere vinto una battaglia decisiva. Opacità contro brillantezza. Anonimato contro memorabilità. Non è il problema di tutti?»
Giovanni Jervis dice qualcosa di importante a proposito dell’identità e, di conseguenza, a proposito della sua dissoluzione: l’identità non è data una volta per tutte, è piuttosto un punto d’arrivo, una costruzione sempre attiva. Ecco, ne La città dei vivi, in questo incedere di voci, ciascuna in qualche modo coinvolta nel rito sacrificale, questa presenza sembra essere mancata, e forse la denuncia di Nicola Lagioia è proprio qui: abbiamo barattato la ricerca libera, spontanea dell’identità della persona con un bisogno feroce, primordiale di riconoscimento sociale che si traduce in orrore: omicidio, sacrificio dell’innocente, deragliamento di ogni ricostruzione possibile. Terminata la lettura mi è rimasta, con l’amaro in gola, una domanda che forse non può avere risposta: cosa è rimasto dell’identità delle persone, cosa, al di là delle maschere con cui si mostrano invincibili?
Nicola Lagioia, La città dei vivi (Einaudi, 2020)
Monica Pezzella esordisce con Binari, un romanzo sperimentale, con qualche vago richiamo a Faulkner, Wallace e Purdy. Una storia d’amore tragica, in un luogo di attraversamenti. Un libro che fa del linguaggio lo snodo, tessendo attentamente, mirabilmente, una trama quasi invisibile; flusso di coscienza, con pochissime virgole, cadenzato, spezzettato e poi ripreso, mai pensato, sempre esperito, che inizia dalla fine e termina con un inizio senza ritorno. All’inizio, ovvero alla fine da cui la storia prende le mosse, ci troviamo in un altrove che somiglia a certe periferie americane, con un Motel, un’evocazione di prostitute, ma poi ancora in un circolo di iniziati, trascinati in discorsi filosofici che hanno per oggetto l’amore ma è un amore disincarnato, sembra quasi una Parigi di fine Ottocento, non ho potuto non pensare a Rimbaud.
La fisicità dirompente di Marcel, architetto, bisessuale, affetto da una malattia inconfessabile e inconfessata, l’erotismo estremo di questo trentenne nichilista e disilluso, seduce donne, giovani e meno giovani, e uomini, come Ale: l’unico di cui Marcel s’innamora.
L’ipersensorialità è un viaggio, a tratti lisergico, che afferra città, stanze e carni dei protagonisti scaraventandole addosso al lettore: è letteratura verticale, fisica, ma anche occulta. L’eterno assente presente è il non detto, perciò alcuni passaggi appaiono oscuri ma ancora più pregnanti per la loro incomprensibilità, ciò che sappiamo è narrato da una voce. Cos’è? È qualcosa di incorporeo, quasi una maledizione, tutto conosce e tutto osserva, stoicamente, ma come Cassandra non può cambiare il destino dei protagonisti.
Un libro capace di presentare in modo diretto, e non rappresentativo, l’ambivalenza tra amore e odio, desiderio e pulsione di morte. I due protagonisti sono vivi, affascinanti, terribili, e l’erotismo è batailleianamente spinto fino a stravolgersi nel suo opposto: un senso d’angoscia e vuoto, tipico di certe forme di amore passionale, narcisistico, per cui la perdita dell’oggetto del desiderio coincide con la perdita di una parte di sé, o di tutto il sé.
«Bisogna ammettere, adesso, che è esistito un incalcolabile momento durate il quale questa Voce ha guardato da un’altra parte ruminato l’idea di qualcos’altro. Deve dirsi la verità, questa Voce. La verità è che li ha odiati entrambi ma non c’è mai stato niente che ha voluto di più e e se ha cercato ovunque quello che cercava erano comunque loro. La condanna è essere ancora qui - è a questo punto che l’ha pensato? - senza la benché minima intenzione di uscire fosse pure con l’eternità inchiodata nel vuoto immobile ma qui dentro lontano lontanissimo da sé».
Monica Pezzella, Binari (Terrarossa Edizioni, 2020)
Le scarpe del Flâneur di Jonathan Rizzo è una silloge poetica dedicata a Parigi, e riverberano in lontananza Baudelaire, Rimbaud, Ginsberg, Bukowkski; a suo modo anche questo è un libro di voci. Voci che arrivano dai boulevards, dai cimiteri, dai dipinti, dalle poesie, dagli amori, dagli ubriachi, dai clochard, dalle segrete di una Parigi antica e sommersa. Il vento, costante presenza, crea, spazza via, rinnova. Deragliamento di un’esistenza liminale che cerca il veleno, nelle periferie cieche, nelle baracche, tra la Senna e un cielo cinereo, in cui la pioggia, come il vento, cancella e ricompone. «Ogni parola, virgola, sillaba e respiro sono stati vissuti sulla pelle. Camminare tra quelle persone che non finiscono in prima pagina e di cui a nessuno importa. Divenirne indegnamente paroliere e coperta» dice l’autore.
Lo stile è viscerale, essenziale, non lineare ma trasversale, ha l’andamento della ballata, della canzone scritta con ironica malinconia e soffuso incanto per un altrove sempre presente, una città che si traduce in luogo invisibile.
Alcune poesie sono tradotte in inglese e francese rispettivamente da Francesca Ferrati e da Martino Trassinelli.
Bastiario parigino
Sgattaiola nel calpestio de li uomini,
anime in contrabbando fragile.
Io non fumo. Dovrei iniziare a fumare.
Compro da bere. Io bevo. Dovrei smettere.
Sono solo. Aspetto
la mia donna e il suo portafortuna tra le gambe.
Arriveranno con le strade lavate di fine estate.
Scrivo così bene a Parigi, solo per me stesso.
Non c’è fretta che il tempo cambi.
Filtro assenzio e pasti coi miei pari.
…
Jonathan Rizzo, Le scarpe del Flâneur (Ensemble, 2020)
Un romanzo che affronta la complessa tematica dei disturbi mentali: narra di Julian Tartari, un ragazzo affascinante e fragile, affetto da schizofrenia.
Si tratta di un libro impegnato a sostenere la legge Basaglia, pubblicato in concomitanza con il quarantennale. Cristina Caloni ci consegna un ritratto molto tenero di Julian, e racconta un complesso rapporto d’amicizia. Induce il lettore a riflettere sul peso lasciato sulle spalle delle famiglie nel caso della malattia mentale; racconta in che misura le vite degli amici e dei familiari vengano travolte dal dolore della fragilità.
"Voleva mantenere il controllo sulla sua vita, non lasciarlo in mano mia, e questo mi ha sempre irritato. Abbandonarsi a me, diceva, sarebbe stato un tenero suicidio. «Ma tu non sei Antonin Artaud e io non sono Anaïs Nin», mi ripeteva. Avrà ripensato alla mia poesia preferita, Réversibilité di Baudelaire. «Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Et la peur de vieillir?». L’avrà confortata sapermi libero dall’angoscia e dalla paura di invecchiare. No, non conosco le rughe, sarò eternamente giovane.
Si sarà addormentata stringendo il ricordo di una notte d’inverno, quando camminavano nel parco, calpestando le foglie di ginko ghiacciate. Si sarà svegliata piangendo, perché il primo pensiero della mattina sarà stato la mia morte."
Cristina Caloni, "La mia stagione è il buio", Castelvecchi, 2019
Dal romanzo è stato tratto un audiolibro a cura di Lorenzo Loreti e Filippo Casanova.
Quattro storie di donne che si sono perse e cercano di ritrovarsi: Teresa (la donna-fuoco), Rosa (la donna-aria), Libera (la donna-terra) e "lei" (la donna-acqua), abitano ciascuna un’isola mentale e vitale, partono da una mancanza, quindi da un vuoto, per diventare un pieno. L’isola è metafora di un luogo protetto che appartiene a ciascuno di noi, e in cui possiamo custodirci per tornare al mondo.
Un libro che c’insegna a fare tesoro della nostra originalità e, soprattutto, dei momenti di difficoltà, per trarne forza e vigore, anzi, per trarne l’essenza più intima di ciò che siamo.
"A Teresa non era mai importato di vivere in un luogo piuttosto che in un altro. A patto che fosse inondato di luce. Si vantava di essere libera da quel tipo di condizionamento. Che fosse centro o perferia, paesotto o metropoli, strada affollata o deserta, questo o quel paese del mondo. Si dichiarava priva di discernimento in materia topografica. Diceva che era per il suo prolungato vagare, dei tanti traslochi, cambiamenti climatici, modi di vivere, vicini di casa, portieri, compagni di banco. Quanti primi giorni di scuola! Quante stanzette dai muri deserti da riempire con l’anima!
Ogni volta si faceva coraggio pensando “Questa sarà per sempre”. E puntualmente la vita la smentiva. Trascinandola altrove, inun’altra stanza forse-per-sempre."
Gabriella Romano, "Isole", Cooper, 2020 (riedizione di Isole, Centro Doc. Giornalistica, 2011)
Mariano Lamberti, con una voce sempre originale e ironica, racconta la storia di un incontro generazionale importante. Si tratta di storie intrecciate: Max, Federica e Massimo. Max e Massimo sembrano essere, già dal nome, alter-ego di una stessa persona declinata nelle diverse sfaccettature che fanno capo a diverse epoche. Uno vive nel nostro tempo, l’altro nell’epoca nazista. Massimo è un soldato italiano, catturato dai nazisti, che dovrà fare i conti con ciò che la Arendt definì male radicale, prima, e poi banalità del male.Federica, sorella di Max, è una donna che deve fronteggiare una separazione, un allontanamento, una grande crisi. Ma la figura centrale del romanzo è Max, pittore, omosessuale, dedito alle chat erotiche e spaventato dai sentimenti, che decide di lasciare il lavoro per vivere da bohémienne, cercando di creare l’opera perfetta.
Queste esistenze sono destinate a intrecciarsi, come se il destino, o il karma, le spingesse una verso l’altra.
"Con il suo primo computer si era quindi manifestata, come per una larva dopo la muta, la verità vischiosa del suo sentire autistico e maniacale, la sensazione di venire per la prima volta accettato e apprezzato, pronto a spiccare il volo nei cieli bassi dei piaceri carnali.
Quel catalogo infinito di corpi, visi, membri, tutti consumati voracemente, in maniera fredda e passionale allo stesso tempo, era diventato la voce interiore e autentica delle sue manie.
I problemi sorgevano quando veniva a contatto con qualcuno che gli piaceva oltre il semplice amplesso, quando da quel groviglio di carne spuntava un viso furbo, canagliesco, che gli accendeva altri sensi, altre tenerezze; un certo tipo di ragazzo che apriva le dighe della sua sottomissione.
Raramente, se non mai, gli capitavano tipi così; fanciulli dai visi segnati, fiori ammaccati nel fango con timide, inespresse volontà di dominio, tutta la potenza di un corpo ancora non fiorito ma già appesantito dalla vita."
Mariano Lamberti, "La vita nascosta del tempo presente", Le Mezzelane, Historica, 2020
La protagonista, Mara, è una madre che perde la figlia e dovrò farsi carico del dolore dell’assenza, tornare a districarsi nei trascorsi sofferenti che hanno attraversato tutta la sua vita.
Ciò che colpisce in Enza Alfano è il lavoro sulla lingua, che è un lavoro diametralmente opposto rispetto a quello dell’erudito, e infatti il romanzo si beve: il lavoro della Alfano è una ricomposizione di pensiero - in terza persona - e parlato. È interessante la sua capacità di riportare il parlato e i pensieri, come un dialogo sempre presente tra scrittore e lettore, un dialogo qui riuscitissimo, che crea subito empatia.
"Della sera prima non ricordava nulla se non quel senso di mancanza. Rientrando in casa dopo i colloqui scuola-famiglia, non aveva trovato Camilla come tutte le sere. Doveva sapere così che se n’era andata per sempre.
Era giunto il tempo dell’accettazione, stranamente si sentiva calma, nessun dolore allo stomaco, conato di vomito, brivido o accesso di caldo. Niente. Ebbe voglia di alzarsi e fumare una sigaretta sul balcone facendo entrare aria in quel giornata nuova."
Vincenza Alfano, "Sopravvissuti", Polidoro, 2020
Le sue poesie sono flussi di coscienza elettrici e taglienti, sassi lanciati contro l’indifferenza, espressione di quella fragilità, a tratti disturbante, da cui sgorga una potenza primordiale. Finalmente una poetessa che torna alle origini del sentire, alle emozioni pure! Giorgia Deidda è capace di scuoterci profondamente, di scaraventarci nel baratro profondo, visionario e abissale, di un’intima, indicibile verità sugli umani, tutti.
Se
mangiavo gli occhi
nel cervello il giorno in cui
caddi coi fogli e i sassi in pancia,
era per farmi passare,
aspettare la luce il rosso
fango che trascino.
Una finzione
lo spioncino che dall’osso
va nel buio della notte.
Giorgia Deidda, "Sillabario senza condono", PlaceBook, 2020
Una poesia colta, non di semplice fruizione, ma certamente frutto di studio e commistione di arti, come dimostra l’apertura della silloge, con una dedica al grande Alfred Schnittke; una poesia per Mario Benedetti e altre dediche che fanno intendere l’amore profondo e la dedizione con cui l’autore si è consacrato all’arte. Sempre presente il tema della mancanza e della disperazione, che però si ricompongono in un luogo misterioso e onirico dove tutti, vivi e morti, sono liberi di amare e lasciarsi attraversare.
Se ci fosse un luogo dove gridare aiuto,
se l’ombra altrui non mi trapanasse il cranio,
se l’occhio di Dio non sapesse chi sono
…
Stelvio Di Spigno, Minimo umano, Marcos Y Marcos, 2020
Davide Toffoli non è classificabile in alcun modo, come scrive Gabriele Galloni nella sapiente prefazione. È un libro, questo, davvero eterogeneo, dove però non è mai smarrito lo spirito d’osservazione, si tratta di descrizioni liriche di luoghi, città, paesaggi; e poi, ancora, haiku, e paesaggi interiori.
Non ci sono cause da difendere, solo una profondità così dettagliata da annientare il confine tra uomo e vissuto, non esiste un confine, i poeti non possono averne.
Verdi presagi.
Atterrano tremuli,
sazi di vento.
Davide Toffoli, "L’infinito ronzio", Controluna, 2018
La poesia di Emiglio Ceglia sembra venire da un’altra epoca, riecheggia l’ermetismo italiano, Quasimodo più che Ungaretti. Si tratta di una silloge per nulla immediata, anzi, molto lavorata, a tratti contorta, e - come ho detto all'autore - molto distante dalla mia concezione di poesia, ma mai banale. Ecco, si potrebbe dire soprattutto questo: una ricerca dell’assoluto dove ogni banalità è bandita. Il lavoro certosino sulla parola, in modo da trovare di volta in volta il termine meno usato, sembra appartenere a un poeta primo-novecentesco, che affronta, per altro, con spirito mitteleuropeo le ragioni dell’agire, del sentimento morale e sociale, con uno sguardo attento alla bellezza, che sia quella di una donna o di uno stato del sé.
…
Eri lì
sepolta nel tuo maniero
esso stesso cinto
tra le mie mura
Perché sei parte di me
Perché sei me.
…
Emilio Ceglia, La strenna, Poetica, 2020
"Scrivere è amare di nuovo" di Rossana Campo è uno dei più bei libri che mi sia capitato di leggere ultimamente. Ho ritrovato la dolcezza dei laboratori di scrittura di Rossana, che per certi versi sono anche dei laboratori di analisi del sé, in cui attraverso la letteratura si è chiamati a intraprendere un percorso iniziatico per cambiare la propria vita.
La Campo è una ribelle, i suoi libri incidono profondamente sulla realtà, chiedendo ai lettori di andare in profondità nella vita apporta dei cambiamenti sostanziali nella costruzione dei rapporti con gli altri. Lei è una rivoluzionaria perché dice ciò che nel resto dei laboratori di scrittura, editing, e in altri laboratori redazionali non sentirete mai: non esistono regole predefinite, buona scrittura prefabbricata, esiste la possibilità di avvicinarsi alla verità di quel che si è, in ultimo, una sola storia originale: la propria.
Non si scrive con le parole, si scrivono le parole perciò Rossana Campo mi fa pensare alla Lispector, la cui lingua sorgiva crea mondi. La scrittura è una seconda nascita e si nutre di tutto ciò che può: letture, arte, filosofia, amori, sofferenza, gioia, spirito d’osservazione, sensorialità, percezione, emozioni, consapevolezza. In questo libro, se lo leggete attentamente, è delineato un percorso di letture che è anche un percorso che conduce dalla percezione alle emozioni, dalla scoperta della propria personale natura alla scoperta di un’etica, un modo per stare con gli altri. Da Nietzsche a Virginia Woolf, passando per Marie Cardinal e Gertrude Stein, Rossana Campo ci invita a scoprire l’outsider interno e a prendercene cura, solo così potremo dire qualcosa di vero con la scrittura.
Con un’attenzione particolare alla letteratura delle donne, a partire dall’istanza sia politica sia mistica, della donna come creatura capace di una potente interiorità, Rossana delinea un mondo che non è mai uguale per tutti, ciascuno può scoprire il proprio e raccontarlo. Perciò, buttate i manuali di scrittura, leggete, studiate e scrivete con amore per voi stessi e per il mondo.
«Quando scrivete, perdete il controllo, non lasciatevi irretire dal pensiero ordinario. Nella vostra vita, buttatevi in situazioni nuove, e poi scrivetene. Se tutti pensano che un barbone seduto su una panchina con una mezza dozzina di bottiglie di birra vuote intorno sia qualcosa che va immediatamente giudicato e schifato, voi potrete invece aver voglia di fermarvi a fare due chiacchiere con lui, e guardando da vicino i suoi occhi azzurri e le rughe e la pelle sporca indovinare il ragazzo bellissimo che doveva essere a sedici, diciassette anni, e immaginare la sua storia».
Rossana Campo "Scrivere è amare di nuovo" (Giulio Perrone Editore, 2020)
Giorgio Ghiotti è un poeta che raggiunge la complessità mediante la semplicità. I suoi versi sono intrisi di una profonda consapevolezza e cultura poetica, di una precisa scelta stilistica e, se vogliamo, politica.
Le parole sono un alfabeto primitivo, possono al tempo stesso disvelare e velare, arrivare all’emozione in modo obliquo, quasi per caso, mentre si passeggia per le strade di Roma, Bologna, Milano, città che sono sempre qualcosa in più che semplici luoghi.
L’adolescenza, la giovinezza, una specie di malinconia, la capacità di raccontare la vita, nel frastuono e nel silenzio, e l’amore, con eleganza, senza mai dire troppo: la sua è una poesia del non detto. Dalla scuola romana mutua la capacità di raccontare l’essenza dei personaggi con poche pennellate, e dalla classicità, invece, tutta l’eleganza del sottaciuto.
(Che cos’è la poesia?)
È un barlume, una storia segreta,
Un parlare fitto di voci
Che neanche sono più qui.
Calendari privi di date, alte e basse maree,
rapide e sponde. È nome che ad altro
nome risponde. È un indugio della memoria,
Barlume e storia segreta.
È musica del tempo che ci allieta.
Giorgio Ghiotti “Alfabeto primitivo” (Giulio Perrone Editore, 2020)
Simone Consorti è capace di scrivere con pungente ironia, lasciando una traccia sulle macerie del presente, con una voce unica, insieme disperata e divertente; tanto più disperata quanto più ironica, di una spietata crudeltà che però va nel profondo, sembra un gioco, ma è un gioco serissimo, che rivela gli aspetti più inquietanti della nostra quotidianità.
"Vi dichiaro marito e morte" sono dieci racconti d'amore e morte, ma senza traccia di romanticismo. In "Portare il cuore di un santo" un uomo cinico, che avvelena animali senza un reale motivo, porta, a seguito di un trapianto, il cuore di un parroco diventato, dopo la sua morte, santo, suscitando gli interessi di un politico populista, che vorrebbe manipolarlo ricattandolo. Ne "Il prescelto" un predicatore, considerato dalla sua setta una specie di santone, organizza un suicidio di massa, ma è indeciso se unirsi ai suoi adepti. In "La pallottola d'argento" due coniugi si litigano l'affidamento di un figlio, ma, contrariamente al celebre film Kramer contro Kramer hanno tante ombre nella loro vita. In "Al mio paese le donne non parlano" quattro ragazzi italiani, vivono una disavventura in Marocco. Sono costretti a comprare una quantità enorme di fumo e litigano furiosamente su cosa farne. I due racconti incentrati sulla paternità, ovvero, "Lei è il papà di Federica?" e "I papà di Anna" affrontano, in chiavi e con toni diversi, il tema dell'impotenza dei genitori nel guidare la vita dei figli.
«Sono solo tre, le pasticche finte. Le altre sono tutte avvelenate e contengono una dose letale. I miei discepoli loro sono quattrocentotrenta, tutti in fila, ognuno ad attendere la sua pasticca come un’ostia a Pasqua. Nemmeno Gesù avrebbe fatto tanto. Lui offriva la resurrezione, non la morte, altrimenti chi l’avrebbe messa in bocca, quella sua ostia! I miei discepoli, invece, lo sanno che in questo mondo non ci ritorneranno; ne erano consapevoli già quando hanno varcato il cancello di questa tenuta, ma tanto più lo sono adesso, non possono non esserlo, dopo il mio discorso di ieri. «I reparti speciali sono a pochi chilometri» li ho informati dall’altare, guardando negli occhi la folla anonima. «Hanno un permesso per entrare. E un altro, firmato dal Governatore, per sbattermi in carcere. Così ho deciso di precederli e raggiungere domattina stessa all’alba nostro Signore. Chi verrà con me sarà salvo; chi, invece, vorrà andarsene è libero di farlo». In realtà, le cose non stavano proprio così: le mie guardie pattugliavano il recinto e, comunque, stanotte solo in venti hanno provato a scappare e in pochissimi ci sono riusciti; qui dentro i reparti speciali non troveranno traditori, semmai gente fedele, che ha fatto fino in fondo il suo percorso. Sta di fatto che, se si avventureranno fino al bosco, scoprendo le sepolture senza date né nomi, penseranno subito a fosse comuni. A quel punto, per me formalizzeranno l’accusa di eccidio, aggiungendola a quelle di circonvenzione, plagio, sequestro di persona, estorsione aggravata, tortura e riduzione in stato di schiavitù. Insomma, un lunghissimo elenco, una specie di record, e tutti i miei discepoli erano indignati, ieri, quando gliel’ho letto. Adesso sono in fila per guardarmi da vicino e ascoltare quel che gli dirò personalmente; sarò la loro immagine finale e l’ultima frase che udranno prima di trapassare. Io, invece, me ne andrò dopo aver guardato negli occhi tutti loro. Dicono che, nell’ora del Giudizio, ti passi la vita davanti, ma io, faccia dopo faccia, vedrò sfilare la vita degli altri».
Simone Consorti “Vi dichiaro Marito e morte” (Ensemble, 2020)
Riporto qui gli ultimi versi del componimento più bello del libro: "Visione di Antonia Pozzi".
...
Nasci fanciulla,
tramutata dagli dèi in maschio
e reso invulnerabile.
Sotterrato da una gragnola
di tronchi d’albero
nel corso di un’imboscata tesa
dai tuoi nemici incapaci
di catturarti, ti libri in volo
ritornando portentosa
femmina
di Astore del Nord.
Cataldo Dino Meo “Amorosa” (VideoAlok, 2020)
"Vodka Siberiana" è il nuovo libro di Veronica Tomassini, si tratta di un’autopubblicazione, perché la scrittura è un lavoro (oltre che una vocazione) e deve essere retribuito degnamente. La voce di Veronica Tomassini è unica, ineguagliabile, per questo ciò che si dovrebbe augurarle è di vivere di scrittura, dal momento che ne ha diritto più di molti altri.
Nel romanzo abbiamo due mondi che si compenetrano, a tratti s’identificano: l’est e il sud, narrati mediante lettere che non sono lettere ma funzioni religiose. Protagonista, una donna che ricorda il passato in seconda persona, un passato destinato a un altro sé, che accoglie il vissuto frammentato nel tempo, le sue relazioni tossiche eppure estremamente umane, proprio per questo estremamente umane. Vite marginali, ebbre, trafitte da un desiderio implacabile d’infinito.
Veronica Tomassini racconta il disagio, la povertà, la periferia ma lo fa con una tenuta stilistica altissima, in ciò risiede la sua sfida: raccontare storie minime con una lingua massima, rendere onore alla disperazione. La differenza è il segno che si fa chiodo, il tratto costitutivo dell’esistenza, ciò che ci rende dissimili dalla bestia e dall’ordine numerico.
I paesaggi sono metafisici, anche se possiamo intuire dove ci troviamo, dai nomi, dai riferimenti letterari, dalle insegne, dalle descrizioni liriche, in realtà siamo in un altrove assoluto, dentro un'anima, in una periferia archetipica.
Veronica Tomassini prende le mosse da Limonov di Carrère, lo fa proprio, e narra una storia che non può essere disgiunta dal vissuto, dalle suture della memoria.
Il coraggio della Tomassini è triplo: storie dal margine, lingua altissima e, per di più, questa volta, autopubblicazione.
Come scrive Davide Brullo su Pangea, stiamo assistendo a una rivoluzione e, anche, a una chiamata (sia nel senso di vocazione che nel senso di chiamata alle armi).
«Parlavi con il professore ed era bizzarria e stranezza ovunque e ovunque per questo si ristabiliva l'ordine giusto dei fatti, che si succedevano, abnormi, compassionevoli, in casa della creaturina tutto era perdono. La vita stessa entrando in casa della creaturina diventava una preghiera incessante, voi con le vostre sventure, la vostra amoralità sopra la considerazione del buon gusto, diventavate preghiera, persino voi, intendendo la breve ressa convulsa di richiedenti qualcosa. Derelitti, orfani dell'indulgenza e tuttavia affogati nell'indulgenza che vi attraversava, come una ferita si apriva e lasciava che esondando l'empietà si colmasse di mestizia e misericordia. Misericordia. Hai cominciato allora forse - non ricordi bene, ma è probabile - a pronunciare la parola: misericordia. E più terribile dell'amore è la pietà. E ancor di più la misericordia. Terribile: che non ha mai fine. Terribile come un confine dell'eternità.
Vedi? Non sono folgorazioni? Tutto sommato, non lo sono?
La pietà ti è stata inoculata anche se vogliamo. Con quella gente lì, quei balordi. Come Limonov guardando al suo paese dopo Chruscev, Breznev. La sua gente. Un popolo che non avrebbe avuto mai una vita normale. Piuttosto - scrive Carrère - volti verderame, ma mai rubicondi. Piuttosto treni devastati dall'uggia, un'uggia sovietica, la povertà costipata, come in una camerata, passeggeri miseri, con miserie in valigie legate, disadorne provviste, conserve nauseabonde. Una rimessa insopportabile di umiltà e resa. Limonov indovina il terrore ingenerato dalla pietà. Un terrore che non sa smettere, l'espiazione su larga scala, rimbalza fino a noi, diventando pietà, preghiera. O lo chiamerai terrore.»
Veronica Tomassini "Vodka siberiana" (autoproduzione, 2020) - in via di pubblicazione (23 settembre) e già ordinabile presso l'autrice.
***
Marilù Oliva ci consegna un libro coraggioso e difficile (da scrivere, non da leggere): una riscrittura dell'Odissea al femminile, mediante i monologhi di Calipso, Nausicaa, Circe, Atena, Le Sirene, Euriclea e Penelope. La lingua è pura, trasparente, a tratti pulsionale e irruenta, la scrittura di Marilù, sempre attenta agli aspetti noir, non tralascia quei dettagli macabri e scabrosi propri della Grecia arcaica.
«È da tanto che io e le mie sorelle aspettiamo che passi qualcuno per spolparlo di carni e midollo e lasciar poi luccicare le sue ossa al sole, come miriadi di trofei, scolpiti dalla morte che decorano le coste della nostra isola.»
Marilù Oliva "L'odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre" (Solferino, 2020)
«Gli anni Ottanta colsero l'Italia intera impreparata, ma mica noi di qui: a Paesenovo non poteva fregarcene di meno, tanto che nessuno s'accorse, ma proprio per niente, del cambio di decennio.»
Massimiliano Santarossa "Pane e ferro" (Biblioteca dell'Immagine, 2019)
Demetrio Paolin "Anatomia di un profeta" (Voland, 2020)
























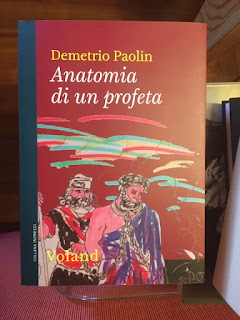
Commenti
Posta un commento